 orniamo
alle birrerie e ai loro impianti a partire dal basso.
orniamo
alle birrerie e ai loro impianti a partire dal basso.
Tanto per cominciare sapete perché si chiama appunto "birra alla
spina"?
Si chiama così perché un tempo, i "fusti" erano barili
di legno e per mescere la birra bisognava piantarci, con tanto di martello,
una "spina" di legno che fungeva da rubinetto.
Come fa la birra, invece oggi, ad uscire dal fusto?
Semplice, nel fusto c'è uno spinone che viene agganciato da un attacco
che apre due valvole contenute nello spinone stesso. su
 Da
una di queste valvole (quella piu' esterna) entra il gas che serve per creare
una spinta sulla superficie della birra consentendo alla stessa di uscire attraverso
l'altra valvola collegata a un pescante che arriva sul fondo del fusto.
Da
una di queste valvole (quella piu' esterna) entra il gas che serve per creare
una spinta sulla superficie della birra consentendo alla stessa di uscire attraverso
l'altra valvola collegata a un pescante che arriva sul fondo del fusto.
A proposito del gas di cui abbiamo appena parlato, c'è da spiegare alcune
cose, e per farlo bene bisogna partire da lontano, cioè da una delle
fasi di produzione della birra: la maturazione.
Durante la maturazione, il lievito aggiunto in vasca si nutre dello zucchero
del mosto e lo trasforma in alcool ed anidride carbonica (co2)
Il contenuto di co2 della birra (detto grado di saturazione) è un aspetto
importantissimo della personalità del prodotto, infatti questo parametro
è prefissato e controllato dai Mastri Birrai che liberano il co2 in eccesso
mantenendolo invariato in ogni processo di produzione.
Il grado di saturazione varia già da marca a marca, anche se il prodotto
appartiene alla stessa tipologia, e varia brutalmente da tipo a tipo (se una
lager ha un grado di saturazione che si aggira intorno a 5 grammi/litro, per
una stout tale valore scende a 2 g/l)
Per spingere il prodotto fuori del fusto, vengono utilizzati tre gas, anzi due
il terzo è una miscela dei primi.
Il piu' usato è l'anidride carbonica che oltre alla spinta, fa in modo
di mantenere un qualsiasi prodotto gassato invariato nella sua frizzantezza
per tutta la durata del fusto.
O meglio, dovrebbe mantenerlo invariato, perché se sbagliamo la pressione
di ingresso del gas nel fusto, siamo i primi a variarla.
Calcolare la pressione giusta non è affatto semplice: infatti bisogna
tenere conto di tanti fattori: ilprimo è la temperatura (pensate nei
cambi di stagione di quanto può variare giorno dopo giorno), il secondo
è la distanza dal fusto al rubinetto in orizzontale e in verticale (impianti
in cantina).
Se applichiamo una pressione troppo bassa, otteniamo una birra, bicchiere dopo
bicchiere, sempre piu' "piatta" (meno gassata) e difficile da spinare
perché il co² contenuto nella birra tende ad uscire dalla stessa
formando delle bolle che quando arrivano al rubinetto creano sbuffi che sparano
fuori dal bicchiere la birra gia spinata lavando il barista.
Se invece applichiamo una pressione troppo elevata, (basta anche che sia scesa
la temperatura del fusto), la birra incorpora sempre più co², gassandosi
sempre più fino che ad un certo punto dal rubinetto esce solo schiuma
sempre più dura e persistente fino a sembrare panna.
Per farvi capire di quanto varia la pressione secondo
la temperatura guardate questa tabella
Temperatura
|
Grado di saturazione (grammi/litro)
|
|
0
|
4
|
8
|
12
|
16
|
20
|
24
|
28
|
32
|
36
|
|
4.3
|
0.35
|
0.60
|
0.85
|
1.05
|
1.35
|
1.36
|
1.95
|
2.25
|
2.55
|
2.85
|
|
4.5
|
0.45
|
0.65
|
0.90
|
1.15
|
1.45
|
1.80
|
2.10
|
2.40
|
2.70
|
3.00
|
|
4.7
|
0.50
|
0.75
|
1.00
|
1.25
|
1.60
|
1.90
|
2.25
|
2.55
|
2.85
|
3.15
|
|
4.9
|
0.60
|
0.85
|
1.10
|
1.35
|
1.70
|
2.05
|
2.40
|
2.80
|
3.20
|
3.60
|
|
5.1
|
0.65
|
0.90
|
1.20
|
1.50
|
1.80
|
2.10
|
2.55
|
2.90
|
3.30
|
3.70
|
|
5.30
|
0.70
|
0.95
|
1.25
|
1.55
|
1.95
|
2.30
|
2.75
|
3.25
|
3.75
|
4.25
|
|
5.5
|
0.75
|
1.05
|
1.35
|
1.65
|
2.05
|
2.40
|
2.90
|
3.40
|
3.90
|
4.40
|
|
5.7
|
0.84
|
1.10
|
1.45
|
1.85
|
2.15
|
2.55
|
2.95
|
3.50
|
4.00
|
4.50
|
|
5.9
|
0.90
|
1.15
|
1.50
|
1.95
|
2.25
|
2.65
|
3.05
|
3.55
|
4.05
|
4.55
|
|
6.1
|
0.95
|
1.20
|
1.55
|
2.00
|
2.30
|
2.70
|
3.10
|
3.60
|
4.10
|
4.60
|
Pressione
da applicare
Il secondo gas utilizzato è l'azoto, il quale differisce dal co2 perché
è un gas inerte, in pratica non dà gusti e non gasa i prodotti,
non viene usato per spingere la birra ma prodotti fermi (non frizzanti) come
ad esempio i vini
Il terzo è il carboazoto vale a dire una miscela di co2 e azoto, il rapporto
più comune è 30 % co2 e 70% azoto, anche se esistono miscelatori
che creano combinazioni diverse prelevando i due gas dalle rispettive
bombole
Questa miscela, è usata per birre con poco tenore di co2, come le Stout
(ad esempio la Guinness, che ha un grado di saturazione di 2,1 g/l) e parecchie
Bitter ed Ale inglesi.
In pratica la parte di co2 contenuta nella miscela mantiene la frizzantezza
e l'azoto serve per la spinta.
La birra, una volta uscita dal fusto, scorre lungo un tubo e verso un refrigeratore.
Ce ne sono di tantissimi modelli e marche, ma si possono dividere sostanzialmente
in due tipi: i soprabanco e i sottobanco. I primi sono impianti molto compatti,
che, come dice il nome, vengono fisicamente posti sul banco, contengono il frigo
per raffreddare i vari prodotti e i rubinetti sono fissati su un lato dello
stesso, i più belli sono molto bassi e hanno una piccola colonnina montata
sul coperchio.
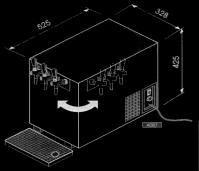
In genere questo tipo d'impianto, soprattutto per motivi di spazio, non ha una
grossa capacità refrigerante ossia non permette grandi erogazioni continue
a temperatura costante.
I sottobanco invece possono essere montati in posizione remota rispetto alla
colonna.
Il principio di refrigerazione è uguale a quello dei soprabanco, ma ne
esistono di tantissimi modelli che variano per numero di prodotti che possono
essere spinati e per potenza refrigerante.
In più del soprabanco, ha una pompa di ricircolo che permette al prodotto
refrigerato, di mantenersi tale per tutto il tragitto che c'è dall'impianto
al rubinetto.
Ma come fa il prodotto a raffreddarsi?
L'impianto è costituito da un frigo, e da una vasca coibentata, nella
quale c'è una serpentina, generalmente di rame, appoggiata alle pareti
e collegata al frigo.
A qualche centimetro dalla vasca ci sono altre serpentine di tubo d'acciaio
inox, tante quanti sono i prodotti da spillare.
Quando installiamo un impianto, dobbiamo riempire la vasca con acqua, che una
volta acceso il frigo, inizia a raffreddarsi fino a formare uno strato di ghiaccio
intorno alla serpentina del frigo, e, ovviamente, anche l'acqua che non è
divenuta ghiaccio è freddissima.
Poiché le serpentine di tubo d'acciaio che vi sono immerse sono generalmente
di lunghezza che varia da otto a ventiquattro metri, il prodotto, passando all'interno
della stessa, ha il modo di raffreddarsi istantaneamente.
Per facilitare lo scambio termico, al centro della vasca è posta una
pompa di ricircolo che ha due funzioni: la prima è di assicurare, tramite
un'elica, l'agitazione dell'acqua fra i tubi delle serpentine dei prodotti e
il ghiaccio, facendo in modo che non si creino zone a temperature diverse all'interno
della vasca.
La seconda funzione è di pompare l'acqua attraverso un tubo contenuto
nel "pitone" (il tubo che porta i prodotti dal frigo alle spine, meglio
spiegato in seguito), vicino al rubinetto di mescita, e la fa tornare nella
vasca attraverso un altro tubo uguale, consentendo ai vari prodotti di mantenere
il freddo anche durante il percorso, nei momenti in cui rimangono fermi perché
non sono spillati.
Il pitone è costituito da una serie di tubi (tanti quanti sono i prodotti
da spillare), più i due tubi del ricircolo dell'acqua.
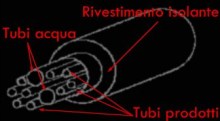 Essi
sono fasciati insieme( in modo che tutti siano a contatto con i due dell'acqua)
e rivestiti da un materiale isolante che aiuta a mantenere il freddo e previene
la formazione di condensa sulla sua superficie.
Essi
sono fasciati insieme( in modo che tutti siano a contatto con i due dell'acqua)
e rivestiti da un materiale isolante che aiuta a mantenere il freddo e previene
la formazione di condensa sulla sua superficie.
Per quanto riguarda l'importanza del pitone, pensate che tante volte si riesce
ad installare il sottobanco sotto il piano dove viene montata la colonna, quindi
la sua lunghezza è limita al massimo ad un metro, ma a volte capita di
dover montare il sottobanco in cantina o nei retro del locale, in questi casi,
si può arrivare anche a diverse decine di metri: immaginate quanti bicchieri
di birra si fermano lì dentro.
A questo punto, non resta che collegare il pitone alla colonna, quest'ultima
ha lo scopo (oltre che reggere il rubinetto) di far risaltare all'interno del
locale i prodotti spillabili, ne esistono di diversi materiali, forme e dimensioni,
alcune sono luminose e comunque costituiscono un importante elemento di arredamento
dei pub e delle birrerie.
Fin qui abbiamo spiegato i componenti di un impianto comune, ora andiamo a vedere
un po' d'altri componenti meno comuni ma non meno importanti.
Come abbiamo visto quando parlavamo della pressione da dare al fusto, l'ideale
sarebbe poterlo posizionare in un luogo a temperatura costante.
Per molte birre come le stout e le ale, la temperatura di erogazione è
molto importante anche per esaltare il sapore del prodotto.
La soluzione migliore per controllare la temperatura è l'installazione
di una cella frigo, che ha molti vantaggi ma anche parecchi svantaggi.
Altro vantaggio, oltre a quelli legati a quanto abbiamo detto prima a proposito
della temperatura costante, è che la birra si conserva meglio (non tutti
i tipi di birra spillati in una birreria vengono consumati nella stessa quantità)
fra l'altro esistono tipi di birra, anche se molto poco consuete, non pastorizzate,
e pertanto vanno tenute al freddo dalla produzione fino all'ultima goccia spillata
(anche se sarebbe meglio dire pompata, poi vedremo perché.)
A proposito degli svantaggi, uno di questi è il suo costo, di fatti finora
ho installato celle solo in irish e schottish pub che avevano i presupposti
per consumi davvero elevati, un altro svantaggio è lo spazio che occupa:
per stabilirne la dimensione bisogna tener conto che all' interno devono trovare
posto sia i fusti da spinare sia la scorta, un fusto deve stare in cella almeno
24 ore per acclimatarsi prima di poter essere spinato, e oltre tutto non possono
essere ammassati ma sistemati con ordine lasciando lo spazio per poter entrare
e cambiarli agevolmente e rapidamente quando finiscono.

 Da
una di queste valvole (quella piu' esterna) entra il gas che serve per creare
una spinta sulla superficie della birra consentendo alla stessa di uscire attraverso
l'altra valvola collegata a un pescante che arriva sul fondo del fusto.
Da
una di queste valvole (quella piu' esterna) entra il gas che serve per creare
una spinta sulla superficie della birra consentendo alla stessa di uscire attraverso
l'altra valvola collegata a un pescante che arriva sul fondo del fusto. 

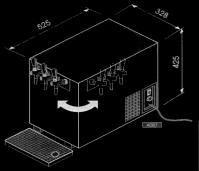
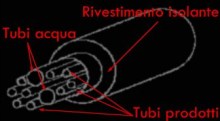 Essi
sono fasciati insieme( in modo che tutti siano a contatto con i due dell'acqua)
e rivestiti da un materiale isolante che aiuta a mantenere il freddo e previene
la formazione di condensa sulla sua superficie.
Essi
sono fasciati insieme( in modo che tutti siano a contatto con i due dell'acqua)
e rivestiti da un materiale isolante che aiuta a mantenere il freddo e previene
la formazione di condensa sulla sua superficie.